di Lourdes Iommazzo
Quando si è piccoli e senza pensieri tutto è più facile. Le parole si dicono senza pensare, si fanno promesse con parole più grandi di noi, di cui non sappiamo neanche il significato e che quando cresciamo dimentichiamo.
Potrei dimenticare tutto tranne quell’estate del 1922 quando tu, Tancredi, con il tuo più grande sorriso e l’ingenuità dei sei anni, mi facesti una promessa che serberò nel cuore fino alla fine dei tempi: che quando saresti stato abbastanza grande mi avresti sposata e che saremmo andati a vivere felici su un’isola lontana – come quelle delle favole, dicesti – lontana dai litigi degli adulti, lontani dalla vita che tutti cercano di propinare; saremmo stati eterni bambini, spensierati e felici. Insieme, per sempre. Io, figlia di un ex prostituta di una delle “case chiuse” più altolocate di Napoli e di uno dei più grandi esponenti della Napoli bene, che dopo “l’incidente” ci garantì un alloggio, a mia madre una marchetta fissa e un lavoro come segretaria di una signorotta, e a me l’istruzione per garantirmi un futuro, diverso da quello toccato in sorte a mia madre, e una sola lettera all’anno. Tu figlio di un avvocato, severo ma con il viso dolce, e di una donna bella come il sole e buona come il pane, il cui lavoro era sfornare torte e dolci per rimpinzarci quando facevamo le gite con tutti i bambini del palazzo. Tu, bello come il sole, capelli biondi ricci, ricci, occhi verdi come le olive appena spremute, le guance grandi e soffici e un sorriso stampato in volto che fa vedere le tue graziose fossette; con le ginocchia perennemente sbucciate con mille cerotti. Io, capelli corvini lunghi e ricci, occhi verdi più scuri dei tuoi tendenti al blu, che quel giorno ti analizzavano in cerca di un qualcosa, un qualcosa che anche dopo anni non riesco a capire.
Ogni estate, lasciandomi un biglietto con una piantina di myosotis o non ti scordar di me, mi ricordavi di quella tua promessa, pregandomi di aspettarti. Io per tutta risposta ti regalavo sempre un mazzolino di primule, di cui una misteriosamente finiva sempre tra i miei capelli. Piano piano, però, si cresceva e s’insidiava in me la paura che questa nostra tradizione per te fosse solo una mera consuetudine, che non t’importasse più della promessa. Vedevo come facevi il seduttore con le altre, regalavi dolcetti e complimenti a tutte; a me invece un sorriso timido e le nostre solite chiacchiere da amici d’infanzia. E quei fiori.
Quando le altre a scuola parlavano di te, della tua bellezza, degli sguardi, dei complimenti e dei piccoli doni, e fantasticavano su un futuro con te come mogli e madri della tua progenie, io annuivo e premevo il mio naso nel libro, come per entrare tra le storie travagliate degli eroi greci e romani e i loro amori impossibili; mentre un nodo nel mio stomaco giorno per giorno si stringeva sempre più. Ero gelosa, ma non potevo dirtelo, non potevo dire di amarti. Avrei rovinato ogni cosa. Tu mi avresti rifiutata e, mano a mano, ti saresti allontanato da me, e io non avrei neanche più goduto della tua amicizia. Quando tu dichiarasti, con i ragazzi in piazza, che t’eri innamorato, il mondo mi crollò addosso. Passavo notti insonni cercando di capire di quale oca giuliva ti fossi infatuato: forse quella bionda dagli occhi cioccolato, oppure la brunetta tutta allegra e pimpante…. Ma una cosa era certa, quella ragazza non ero io. Anche se una parte di me ci sperava.
Vedevo che quando mi avvicinavo a un ragazzo o se qualcuno fuori dalla nostra ristretta cerchia di amici mi ronzava intorno, sembravi rabbuiarti. Passò molto tempo così, anche dopo la scuola. Poi, al fiorire dei vent’anni, successe qualcosa, un qualcosa di meraviglioso. Era uno degli ultimi giorni di giugno, le case nei piccoli borghi fuori Napoli sembravano deserte, negozietti e botteghe erano chiuse per le vacanze, prima dell’arrivo dei turisti dal nord nei mesi più caldi. Anche se la mattina non iniziò bene, perché mancava la piantina di myosotis e dalla serranda chiusa sembravi non essere neanche in casa, trovai la voglia di uscire, per sfuggire al pensiero che ti fossi dimenticato o peggio annoiato di questa nostra promessa.
Misi un vestitino a giro manica, che sull’orlo aveva stampati fiori bianchi che salivano di un paio di centimetri sulla gonna per poi perdersi nell’azzurro notte della stoffa; e una cinturina bianca per segnare per bene il punto vita, un effetto che mi piaceva; indossai una collanina e un braccialetto, sciolsi i capelli e li legai in una mezza coda alquanto spettinata. non mi importava più di tanto, l’unico mio pensiero era uscire. Presi la borsetta dove tenevo un libro, l’Odissea, e uscii. Non sapevo dove sarei andata, ma sapevo che doveva essere il più lontano possibile. Forse sarei potuta scappare, che pensiero sciocco: da cosa sarei dovuta scappare, da un sentimento non ricambiato? Che stupida.
A un tratto, mentre mi perdevo nelle stradine, sentii una mano cingermi la vita e un’altra tapparmi la bocca e spingermi in un vicoletto stretto. Cercai di dimenarmi dalla presa, tentando di urlare. Ma… quando sentii la voce che mi diceva di calmarmi, capii subito che eri tu, Tancredi. Mi calmai. Tu levasti la mano dalla mia bocca e portasti anch’essa sulla mia vita, cingendomi con entrambe le braccia. Mi dicesti ch’ero bellissima, lasciandomi un bacio sulla guancia. Ero rinata. Sembrava quasi che le Moire stessero facendo girare la mia vita nel verso giusto. Tutto mi sembrava vivo e splendente; mi sentivo leggera, quasi sentivo di poter volare e raggiungere il sole.
Andammo verso una casa diroccata nella parte più alta del paesino, con una campagna sterminata intorno. Arrivammo alla porta, io ero troppo felice per chiederti qualunque cosa e sinceramente non mi interessava più di tanto cosa fossimo sul punto di fare, perché stavamo per farlo insieme. La casa dentro era buia, con qualche sprazzo di luce che entrava da piccole finestre; si riuscivano solo a vedere vecchi mobili e quadri ricoperti di polvere e ragnatele. Mi stringesti la mano forte e corremmo fino all’ultimo piano, su un magnifico terrazzo da cui si vedeva tutto il paese e perfino il mare. Lì tornammo come quei due bimbi di sei anni, scherzammo su quanto era tutto più piccolo da lassù, facemmo congetture sul nostro futuro, confidandoci anche i sogni più strampalati, riacquistando quell’intimità, che oggi è concessa solo tra bambini o tra coppie sposate.
Ricordo che d’un tratto ti scostasti da me, ti inginocchiasti e pronunciasti queste parole, che avrei scritto come una ragazzina sul primo pezzo di carta trovato una volta ritornata a casa: “Cassandra, tu sei la ragazza di cui mi innamorai a sei anni. Tu sei la ragazza che ha monopolizzato i miei pensieri da quel giorno; la ragazza che avrei voluto baciare d’impulso davanti a tutti, per fargli capire che eri mia; la ragazza che mi ha tenuto sulla retta via; la ragazza per cui affronterei tutte le fatiche del mondo. La ragazza che è il mio intero mondo. So che non siamo mai stati veramente fidanzati ma, se per te ha ancora valore quella promessa, sposami. Non ti potrò portare su un’isola deserta per restare sempre bambini, ma possiamo vivere soli su questa collina, che è quasi come quell’isola, e posso prometterti che qui non ci toccheranno mai i problemi che affliggono tutti gli adulti. Ti prometto che saremo felici”.
Mentre lo dicevi, dagli occhi verdi che non avevi il coraggio di rivolgere verso di me, scendevano calde lacrime. A me invece uscì un enorme sorriso e, quasi presa da un raptus, ti tirai per il colletto e unii le nostre labbra. Dio solo sa da quanto tempo desideravo farlo. Quel bacio partito come dolce e disperato, era mano a mano diventato passionale, bramoso di qualcosa in più che entrambi volevamo. Ci staccammo per mancanza di aria. Le guance rosse, i respiri affannati, le labbra secche e la gola ancor di più. Il cervello si era fuso, tutto era guidato dalla nostra emozione, o per meglio dire passione a lungo celata e repressa, per paura di non essere abbastanza. Così, non volendo più aspettare, cacciammo via ogni sorta di pudore. I vestiti a poco a poco diventarono sempre di meno, fino a formare il nostro giaciglio, dove fra caldi e umidi baci e mani che vagavano ovunque, ci unimmo quasi come a divenire un’unica persona, come gli androgini di Platone.
Passammo fino a sera il tempo così, a godere l’uno dell’altro. Poi tornammo a casa e tutto parve accelerare. Meno di una settimana dopo confidammo le nostre intenzioni alle famiglie. Inaspettatamente, reagirono bene, quasi come fossimo insieme da tempo immemore. Forse lo eravamo, ma troppo presi a crogiolarci nelle nostre insicurezze da interpretare l’una i sentimenti dell’altro.
Dopo un anno di fidanzamento ufficiale, un lavoro assicurato come segretario di tuo padre e spossanti preparativi per il matrimonio, ci sposammo. La mattina ero agitatissima: era l’ultima volta che sarei stata in casa di mia madre come donna nubile. Indossavo l’abito che lei non aveva mai avuto occasione di indossare: la sua vita era andata a scatafascio dopo la morte del padre, cui un creditore aveva sparato, e della madre, per cancro. Quell’abito era l’unico ricordo che aveva di loro. Prima di diventare una prostituta, pensava di poterlo indossare con l’uomo che l’avrebbe salvata dalla miseria. Ma chiunque le si avvicinasse se ne andava dopo aver soddisfatto le proprie pulsioni naturali, sicché lei aveva deciso di mettere da parte i sogni d’amore e farsi pagare per il servizio. Era ciò che la società si aspettava da una disperata in quella condizione.
Rammento tutte le volte che provava di notte quel vestito e si accasciava a terra davanti allo specchio, piangendo disperata, vedendo il fantasma di una vita mancata, pensando che nessuno potesse vederla o sentirla. E io, una piccola bimba spaventata dalle grida come i latrati squarcianti dei cani, spiavo dalla fessura della porta, temendo che se avessi detto qualcosa dei miei problemi a quella fragile donna, anche lei sarebbe diventata una figura evanescente come mio padre. Avevo paura mi abbandonasse.
Tutti quei pensieri furono scacciati via dalle sue mani che mi appoggiavano in testa una coroncina di fiori azzurri e il velo. Aveva le lacrime agli occhi, così come mia suocera. Non sono mai stata una persona incline a mostrarsi vulnerabile e piangere davanti agli altri, ma – devo dire la verità – anche io versai qualche lacrima vedendo quella scena. Mi guardai allo specchio, per distogliere lo sguardo da loro. Non vorrei peccare d’orgoglio, ma ero stupenda. Il vestito, fatto di tulle e raso, cadeva morbido e ampio sui fianchi e cingeva bene la vita; era appena scollato e aveva le maniche a sbuffo lievemente trasparenti. Portavo i capelli sciolti, con i ricci cadevano dolcemente sul vestito, in contrasto sia con il candore del tessuto, sia con la corona di fiori e il velo in testa. Mi sentivo una vera principessa. Arrivammo in chiesa, addobbata con myosotis e primule, come il mio bouquet; tu all’altare con l’abito nero che faceva risaltare il tuo incarnato pallido e i capelli biondi.
Andammo a vivere in quella casa, non ci era voluto molto per restaurarla. Ma passarono un paio di mesi e quel magico idillio cominciò a svanire. Quando i tuoi morirono, dopo il suicidio di mia madre, prendesti sulle spalle lo studio di tuo padre e con esso tutti i suoi clienti, soci, attività e responsabilità. Era il 1938 e dalla nostra “isola” ci trasferimmo nel centro di Napoli, in una grande casa moderna, per seguire gli affari più da vicino e integrarci con i signorotti, sotto consiglio di alcuni amici. Passavamo di salotto in salotto: l’argomento più diffuso era l’approvazione delle leggi razziali. Mi si torceva lo stomaco dalla rabbia e dal disgusto nel sentire persone osannate come grandi intellettuali e politici molto amici del Duce elogiare leggi contro uomini colpevoli solo d’esser nati.
Ricordo che nel paesino parlavamo di rado di politica e, quando lo facevamo ci trovavamo d’accordo nel disprezzare il regime. Ma da quando eravamo a Napoli mi sembravi cambiato. Dapprima, dopo i salotti e le serate con gli amici dello studio legale, a casa ti lamentavi di quelle idee bigotte e amorali. Ma poi cominciasti ad apprezzare ciò che prima criticavi. Quando constatai la tua adesione al Partito, decisi di parlarti e capire se stessi solamente fingendo: l’uomo che amavo e che avevo sposato non poteva essere dalla parte degli oppressori. Ma mi resi conto che il ragazzo puro di cui ero innamorata era scomparso, rimpiazzato da un mostro.
Ti dissi tutto ciò che pensavo riguardo il tuo cambiamento e tu, senza neanche prenderti la briga di darmi una spiegazione, mi picchiasti, tanto che per paura di morire, appena riuscii a sfuggirti mi barricai in camera da letto. Non volevo ancora crederci, c’era una parte di me che sperava che mi stessi sbagliando. Quella parte di me era rinata quando per scusarti mi portasti sfogliatelle, fiori e un buon libro e non uscisti con quelle persone per una settimana. Ma poi mi permisi di dire mezza parola contro il Duce e tu picchiasti di nuovo. Arrivasti a chiudermi sul balcone al freddo, in pieno inverno, con indosso solo la mia vestaglia da notte. Pensai di dover scappare da te, ma il giorno dopo smuovesti mare e monti per farti perdonare e la mia speranza si riaccese.
Da qui iniziò un circolo vizioso di abusi e gesti romantici. Dopo un anno avevo imparato a stare zitta e sottomettermi, pur di avere affianco a me l’uomo dolce e premuroso che amavo dall’età di sei anni. Ma la situazione divenne insostenibile perché, frustrato dalle sconfitte dell’Italia in guerra e dal fatto che oramai la ribellione prendesse piede tra le masse, ti sfogavi su di me. Era l’inizio di settembre, avevo fatto amicizia con un gruppo di coetanei, staffette dei partigiani, soprattutto con una ragazza di nome Manuela. Conoscevano la situazione in cui mi trovavo, e, pur sapendo che sarei stata pronta a morire per la libertà, non mi hanno mai chiesto nulla. Un giorno invitai Manuela a prendere un caffè a casa, sicura che tu non ci fossi, ma mi sbagliavo: eri lì con altri di quei tuoi amici fascisti. Tenevate prigioniere due persone anziane, che dalla reazione di Manuela capii subito che fossero i suoi genitori.
Davanti ai miei occhi, dietro ordine di quello che definivo mio marito, la torturaste per avere informazioni, arrivando ad uccidere lei e i genitori. Mi stringesti forte il braccio dicendo che avresti pensato a me quella stessa sera. Io, in lacrime, ti guardai dritto negli occhi: quelli che prima amavo, pieni d’amore, e ora scuri, macchiati di sangue e odio. Capii che la speranza che avevo era morta. Tutto quanto avevo sopportato negli anni era per amore di un fantasma, di un’anima che era morta, ma che io amerò per sempre. Quell’anima – o meglio, quel fantasma – è la mia anima gemella e lo sarà per sempre. Fuggii appena te ne andasti, andai a nascondermi in un quartieraccio che ospitava un covo della Resistenza. Oggi, ventisei settembre, scrivo questo testo, a te per parlare ai fantasmi che ci uniscono, murati dentro di noi, separati da scelte contrapposte. Bambini che si aspettano e si amano ancora, ma si uniranno solo con la dipartita da questa forma mortale.
Lourdes Iommazzo nasce a Benevento nel 2005. Trascorre l’infanzia tra musica, libri, film e nella natura sconfinata vicino alla casa della nonna. Ama le lingue e sa parlare discretamente inglese e spagnolo. La scrittura è stata sempre la sua valvola di sfogo, per portare il suo mondo nel mondo reale. Scrivere per lei è diventato il modo per farsi capire ed integrarsi nella società. La partecipazione al bando del premio Torre Crawford è la sua prima esperienza a un concorso di scrittura.
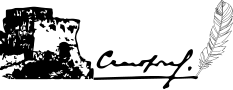


One thought on “Giurin Giurello”
Comments are closed.