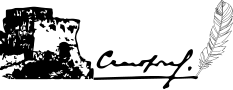L’esperienza è esplorazione di consistenze. Ada D’Adamo partorisce la sua prima bimba. L’esperienza è effervescente, gioia pura. La bimba sembra diversa dal maschietto che sugge vorace il petto florido dell’orgogliosa compagna di stanza. Daria è affetta da oloprosencefalia. Parte del suo cervello non si è sviluppato e nessun medico se ne è mai accorto. La felicità solidifica, diventa pesante. Non lo sarà il corpo di Daria. Lei sublima, è aria. Ada rimanda un controllo periodico al seno per un intervento all’esofago della figlia. Al controllo successivo verrà diagnosticato un tumore metastatico fino alle ossa. Lei è stata una ballerina, vive di danza. È lieve, la malattia la rende sempre più immobile. Come Daria.
Il libro è un diario per lei. Un testamento, una testimonianza. Parla di solitudine, dell’ipocrisia della gente che osserva la disabilità e si volta dalla parte opposta. La necessità di condividere il dolore, laicamente, senza applausi o lacrime. Descrive l’esistenza tramite la merda dello sforzo del parto, il racconto del primo aborto l’anno prima di avere Daria, la potenza di una bimba con i superpoteri perché non parla, non vede né cammina. Una corrispondenza di animi che trascende la corporeità. Non vuole compassione, applausi, solo dignità. Al centro della narrazione c’è il rapporto speciale tra una mamma e sua figlia. Al centro c’è la leggerezza.
Ada d’Adamo è morta recentemente. L’unico modo per descrivere la materia è la parola. Il corpo è materia, la morte no. La letteratura è la parola, unica possibilità per sublimare la morte.