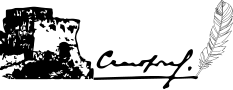“E vidi me stessa seduta sulla biforcazione dell’albero, che morivo di fame per non saper decidere quale fico cogliere. Li desideravo tutti allo stesso modo, ma sceglierne uno significava rinunciare per sempre a tutti gli altri”. Scegliere a quale vita appartenere, quale maschera indossare per adeguarsi all’incedere molesto del tempo. Scegliere di non appartenere, osservando da lontano le decisioni non colte disfarsi come frutti ormai avvizziti. Sylvia Plath racconta, con sfrontata immediatezza, la sua inquietudine attraverso i pensieri di Esther Greenwood. Una studentessa acerba e preparata, che desidera affermare il proprio valore, malgrado l’incompiutezza delle sue decisioni. L’inerzia dei suoi pensieri lotta, in modo veemente, con la frenesia incessante di una società fortemente individualista. Quel feroce mondo esterno si tramuta, ai suoi occhi, in una campana di vetro, che soffoca ogni suo blando tentativo di corroborare anche la debolezza umana. La campana di vetro della pazzia, la precarietà della salute mentale, la guideranno verso il tentativo sfiorato di abbandonarsi al chiarore della morte. La consapevolezza di una tale fragilità è lo strumento brutale che Sylvia Plath utilizza per comunicare la sua stessa sofferenza, anticipando con velato sconforto il suo destino. “Mi sentivo come un cavallo da corsa in un mondo senza ippodromi, o come un campione di calcio dell’università che si trova tutt’ a un tratto di fronte a Wall Street e al doppiopetto grigio, i suoi giorni di gloria ridotti alle dimensioni di una piccola coppa d’oro sulla mensola, con su incisa una data, come una lapide di un cimitero”. Scegliere di rinascere in una nuova dimensione, trascinando con fatica il fardello dei propri affanni. Scegliere di appartenere, almeno a se stessi, perché “Io sono, io sono, io sono”.